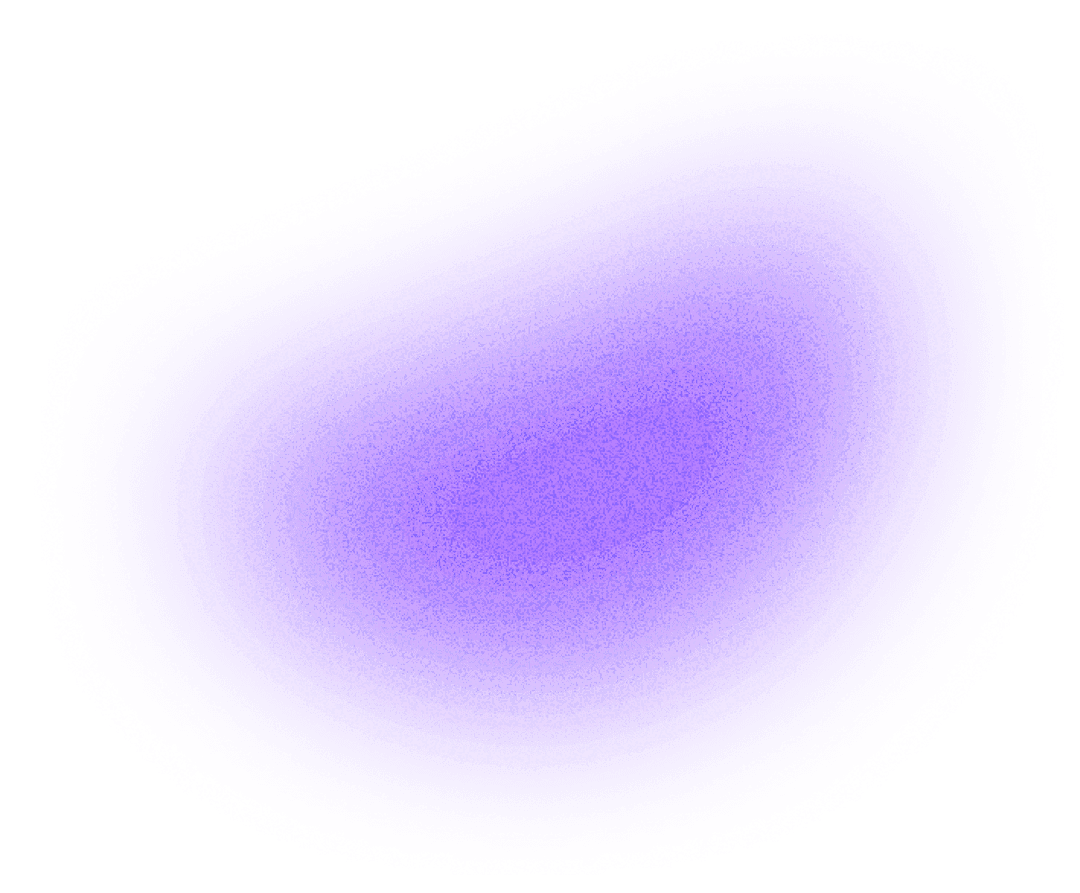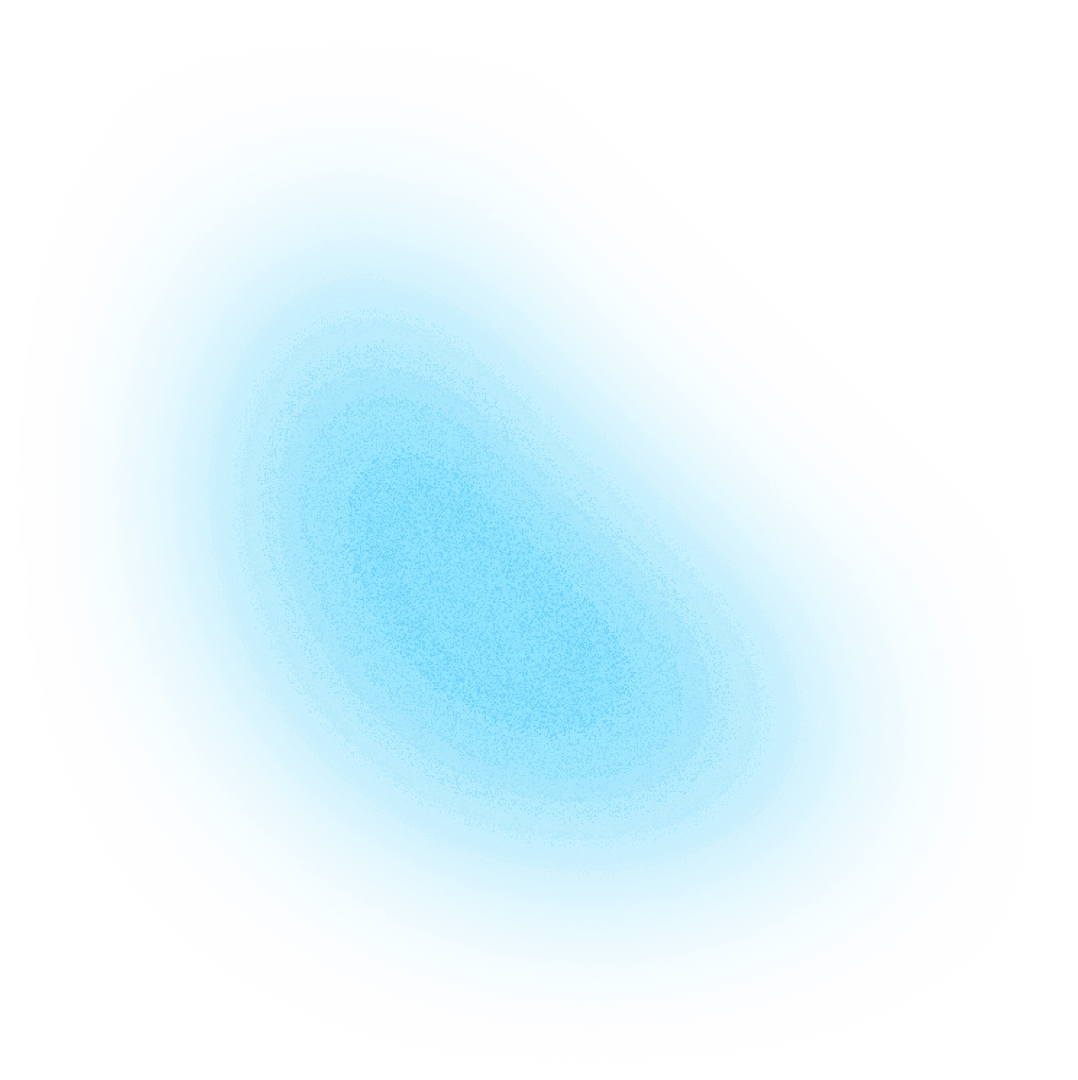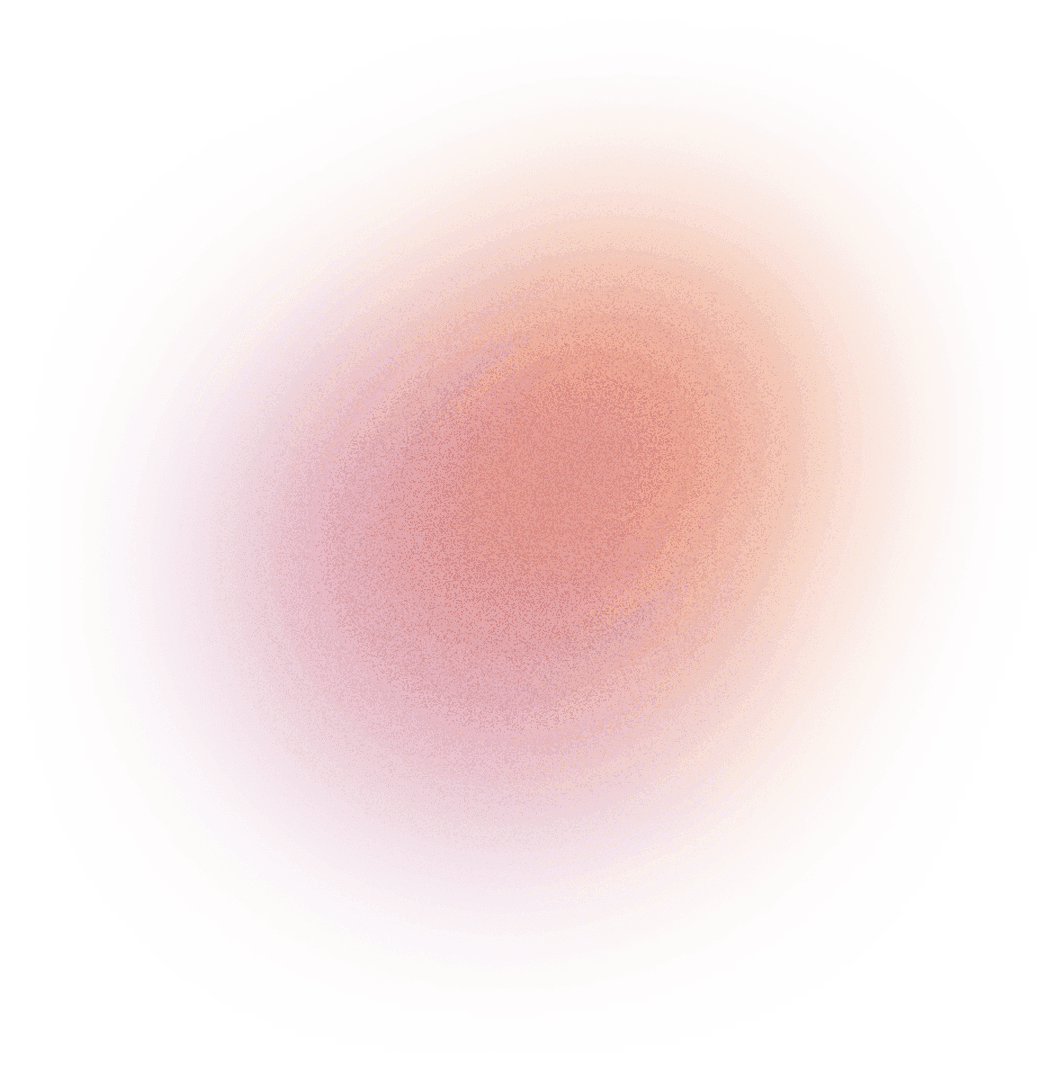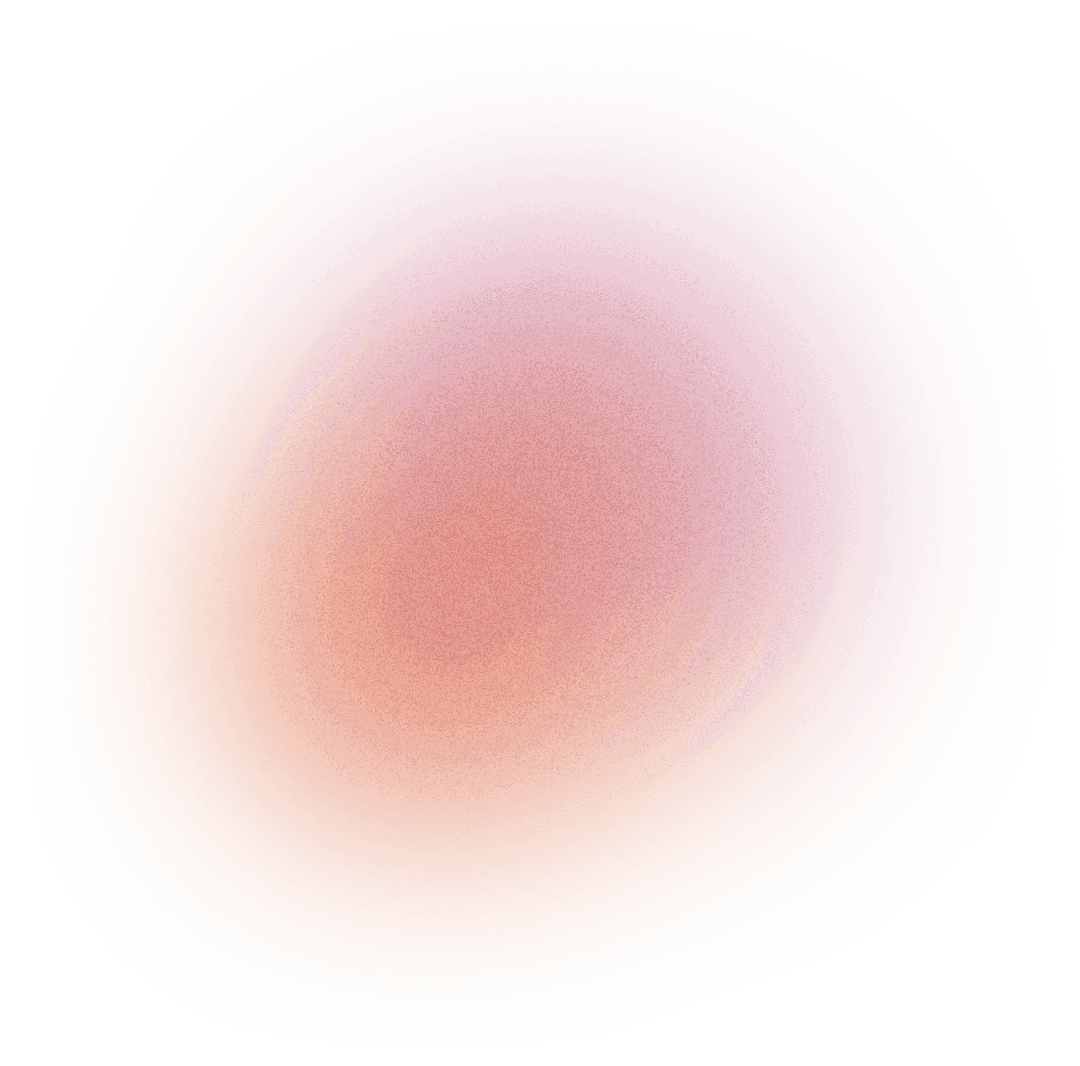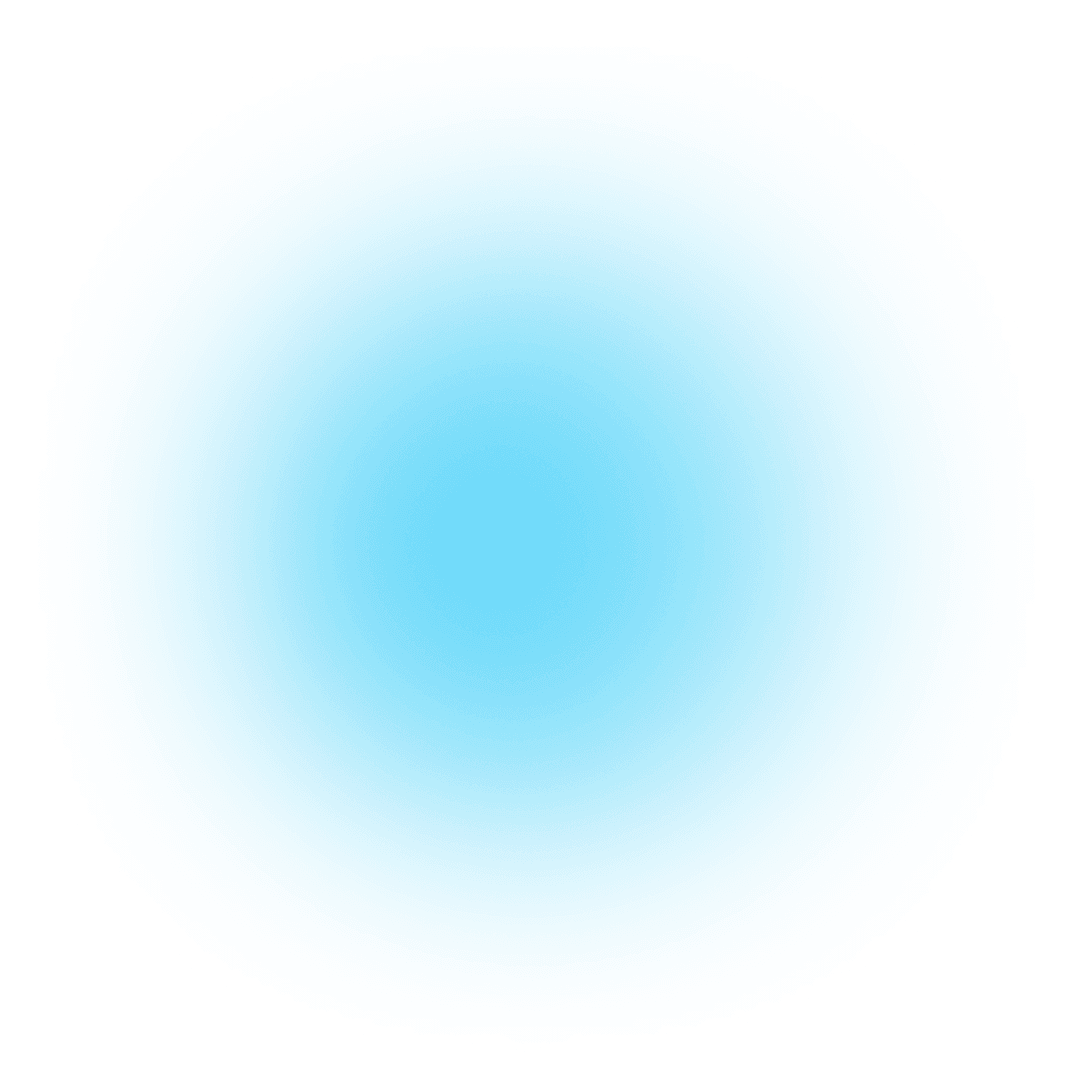30 ottobre 2025
UX e psicologia: come gestire il carico mentale dell'utente
L'utente è pigro o solamente efficiente? Come la Cognitive Load Theory può aiutarci a capirlo meglio
Estenuanti fasi di progettazione, bozze a non finire per disegnare un’interfaccia impeccabile, ore di sviluppo, test, revisioni. Finalmente il prodotto è pronto. Eppure… qualcosa non funziona. Gli utenti sembrano non comprenderlo. Lo provano, lo esplorano, ma presto si stancano e lo abbandonano.
Che cosa allontana l’utente dal tuo prodotto? E se la ragione risiedesse in una cattiva progettazione dell’esperienza utente?
Immagina il cervello come un salvadanaio. Ogni volta che pensiamo, scegliamo o clicchiamo, versiamo una moneta mentale. Alcune azioni costano di più, altre di meno. Un design confuso fa spendere un sacco di monete solo per capire dove andare o cosa fare. Un design chiaro e prevedibile, invece, ci fa risparmiare energia mentale e la mente ci ringrazia.
Spesso si dice che le persone siano “pigre” quando non hanno voglia di pensare troppo. Ma la verità è che il cervello non è pigro: è efficiente. Ogni ragionamento, ogni scelta, ogni dubbio ha un costo cognitivo, e il cervello cerca costantemente la via più economica per arrivare al risultato.
Per essere bravi UX designer bisogna essere anche un po’ psicologi. No, non nel senso di “siamo tutti un po’ psicologi”; parliamo di psicologia vera, quella che si studia nelle aule accademiche e che ha alla base il metodo scientifico.
Perché se gli utenti “abbandonano la barca”, forse non è colpa loro, ma di un prodotto progettato senza tener conto delle regole che governano la mente umana.
Vediamo allora come conoscere le basi della psicologia cognitiva può aiutare a progettare una UX a prova di carico mentale.

Cognitive Load Theory: cos’è e perché è importante per la user experience
Partiamo dalle basi. Quando svolgiamo un compito, la nostra mente utilizza la memoria di lavoro per elaborare le informazioni che ci vengono presentate. Secondo la legge di Miller, però, questo tipo di sistema cognitivo è limitato. In particolare, lo psicologo George Miller parla del famoso “7 ± 2”, cioè del numero medio di elementi che riusciamo a tenere a mente contemporaneamente.
Negli anni ‘80, anche John Sweller approfondisce questi concetti con la teoria del carico cognitivo, o Cognitive Load Theory, evidenziando i limiti della memoria di lavoro. Studiò in particolare i fattori che possono complicare o facilitare l’apprendimento, sottolineando però che tali limiti possono essere superati sfruttando schemi mentali e conoscenze già presenti nella mente. Ovviamente, ciò è vero anche quando si parla di design.
Come si applica la Cognitive Load Theory al lavoro del designer
Facciamo un esempio concreto. Chiunque abbia usato una qualunque app di messaggistica, sa che solitamente troverà un campo di testo in cui scrivere e, alla sua destra, un’icona (solitamente una freccia o qualcosa che ne evochi la forma, come un aeroplanino) che serve a inviare il messaggio.
Questo è un esempio di schema acquisito che può aiutarci ad elaborare informazioni dello stesso tipo quando le incontriamo: riconosciamo il pattern e siamo in grado di utilizzarlo per elaborare nuovi stimoli.
Se volessimo quindi integrare una chat all’interno del nostro prodotto, rispettando questo schema potremmo ridurre il carico mentale dell’utente. Infatti, a prescindere da tutte le feature da cui la nostra chat innovativa sarà affiancata, l’utente riconoscerà immediatamente dove cliccare per scrivere un nuovo messaggio e poi inviarlo.
La sensazione di familiarità è un fattore che gioca a nostro favore. È infatti noto che le persone tendono a preferire elementi a loro familiari: una canzone già ascoltata, un volto noto, il logo di un’azienda già visto in una pubblicità. Questo fenomeno, studiato già negli anni ‘60, prende il nome di effetto della mera esposizione, o Mere-Exposure Effect.
Viceversa, utilizzando un’icona completamente diversa o spostando il pulsante di invio in una posizione inedita, creeremmo nell’utente emozioni negative, un senso di spaesamento e un’impressione di disordine, che potrebbero portarlo a trovarla meno attraente.

Come lavorare sulle diverse fonti di carico cognitivo
Nella sua teoria, Sweller sostiene anche che il carico cognitivo associato ad un compito da svolgere derivi essenzialmente da tre diverse fonti:
- Il carico intrinseco è lo sforzo legato alla complessità stessa del compito. Alcune attività sono semplicemente più difficili di altre. Per esempio, compilare un form con dieci campi obbligatori richiede più attenzione che inserire solo nome ed email. Non possiamo eliminarlo, ma possiamo semplificarlo dividendo il compito in step o mostrando solo ciò che serve al momento.
- Il carico esterno è dipendente da fattori esterni, come la modalità di presentazione delle informazioni. È il peso extra che non serve, ma che si aggiunge a causa di un design poco chiaro o di distrazioni inutili. Un buon design deve ridurre questo carico, eliminando il rumore e rendendo il percorso il più fluido possibile.
- Infine, il carico pertinente è lo sforzo utile che serve a imparare cose nuove, a costruire connessioni mentali. Nel design, significa favorire quelle interazioni che aiutano l’utente a capire meglio il sistema o a ricordarlo per la prossima volta, come un onboarding chiaro, un feedback immediato o pattern ricorrenti che rinforzano la comprensione.
In sintesi, come può uno UX designer far tesoro di questi concetti della teoria del carico cognitivo per migliorare l’esperienza utente? Agendo in maniera differenziata su ciascuno dei tre:
Gestire il carico cognitivo intrinseco |
|
Ridurre il carico cognitivo esterno |
|
Facilitare il carico pertinente |
|
La legge di Tesler: dove psicologia applicata e UX si incontrano
Se è vero che la psicologia applicata dovrebbe far parte del bagaglio di conoscenze di un bravo designer, è anche vero che spesso la troviamo integrata in quelle che vengono ritenute “leggi della UX”.
Un esempio tipico è la legge di Tesler, anche detta della preservazione della complessità, che sostiene che:
- Ogni processo ha una complessità intrinseca, che non può essere semplicemente cancellata. Per noi, ciò significa che quando un utente deve orientarsi su un prodotto nuovo, è inevitabile che faccia fatica.
- La complessità può però essere gestita e spostata dall’utente al sistema. Nel nostro caso ciò significa che il design può farsi carico della difficoltà dell’utente e alleggerirgli il compito, occupandosi delle parti più difficili.
Chiaramente, questa legge ha dei punti in comune con la teoria del carico cognitivo: laddove l’utente incontra una difficoltà, il designer può assumersi il peso di quest’ultima, gestendola attraverso il proprio lavoro.
Quali sono i fattori che determinano una complessità
Quali sono i fattori che determinano quanto “costosa” sia un’azione e, soprattutto, come può il lavoro del design ridurre il costo per l’utente? Ecco alcuni esempi guidati.
Problema. È la prima volta che l’utente si trova di fronte alla tua piattaforma di e-commerce. Tutto gli appare nuovo e deve comprendere come portare a termine il suo primo acquisto.
Soluzione. Un onboarding progressivo aiuterà l’utente indicandogli prima dove cercare il prodotto che desidera, poi come inserirlo nel carrello e infine come completare l’acquisto. È il principio della progressive disclosure, in cui ogni informazione verrà mostrata solamente nel momento in cui è rilevante.
Problema. L’utente è confuso: vorrebbe modificare le impostazioni del suo profilo, ma non sa come accedere alla schermata corrispondente.
Soluzione. Le impostazioni sono, nella maggioranza dei siti e delle applicazioni mobile, associate all’icona dell’ingranaggio. Per aiutare l’utente a trovare esattamente quello che cerca è utile utilizzare un pattern già noto.
Inoltre, una volta all’interno della sezione, semplici accorgimenti gli permetteranno di trovare velocemente l’impostazione specifica di suo interesse: ridurre il numero di opzioni disponibili, raggruppare quelle tra loro simili e mettere in evidenza (ad esempio, in cima alla lista) quelle maggiormente utilizzate dagli utenti.
Problema. L’utente vuole aggiungere un evento al calendario integrato nella piattaforma. Non sa da dove iniziare e teme di invitare per errore l’intera azienda al meeting sbagliato.
Soluzione. Un design pulito e senza fronzoli condurrà immediatamente l’utente alla creazione di un nuovo evento. Ad ogni step gli verranno forniti dei feedback, ad esempio potrà vedere in anteprima come apparirà l’evento a calendario e gli comparirà una richiesta di conferma prima che compia azioni importanti, come eliminare un evento o inviare una mail ai partecipanti.
Per riassumere, ecco alcune strategie pratiche per aiutare il cervello a risparmiare risorse:
- Riduci il superfluo: meno distrazioni = meno sprechi di attenzione
- Mantieni coerenza: gli schemi familiari rendono tutto più intuitivo
- Mostra poco per volta: la progressive disclosure aiuta l’utente a non sentirsi sopraffatto
- Fornisci feedback immediati: l’utente capisce subito di aver agito correttamente
- Premia l’esperienza: permetti scorciatoie per chi usa spesso il prodotto
- Guida con chiarezza: un piccolo tooltip al momento giusto può salvare molte monete
Non tutti i costi cognitivi possono essere gestiti
Se una piattaforma è utilizzata solamente da utenti esperti, pensiamo ad esempio ad un nuovo strumento per la gestione del lavoro dato in mano ad un project manager con anni di esperienza, decade il problema di gestire il carico cognitivo?
Assolutamente no! Ci sono condizioni che comportano un alto carico cognitivo che non possono essere controllate dallo UX designer, neanche quando conosce perfettamente il proprio utente.
Anche il migliore dei project manager faticherà ad utilizzare un nuovo gestionale quando si trova in una condizione di stress, oppure è molto stanco, o ancora è distratto da un ambiente rumoroso e da continue interruzioni da parte di colleghi e clienti.
È proprio in situazioni come queste che una UX robusta e accessibile diventa fondamentale per facilitare il compito dell’utente e cercare, per quanto possibile, di ridurne il carico mentale.

Tiriamo le somme sul designer un po’ psicologo
In conclusione, abbiamo visto come i principi della psicologia cognitiva possano essere applicati efficacemente alla UX per creare un flusso più piacevole e coinvolgente per l’utente. Un utente soddisfatto è un utente che continua a utilizzare il prodotto e che lo suggerisce ad amici e colleghi.
Ovviamente, non è necessaria una laurea in psicologia per apprendere e applicare questi accorgimenti, ma è comunque necessario uno studio approfondito delle leggi che governano la percezione e i processi decisionali.
E il tuo prodotto? Aiuta il tuo utente a risparmiare risorse cognitive o rischia di farlo sentire scoraggiato ed esausto? Se non sei sicuro di come rispondere a questa domanda e vuoi l’opinione di un team multidisciplinare, scrivici: possiamo discutere assieme di come progettare un’esperienza che tenga conto della psiche del tuo utente e lo accompagni passo per passo nell’utilizzo della tua piattaforma.